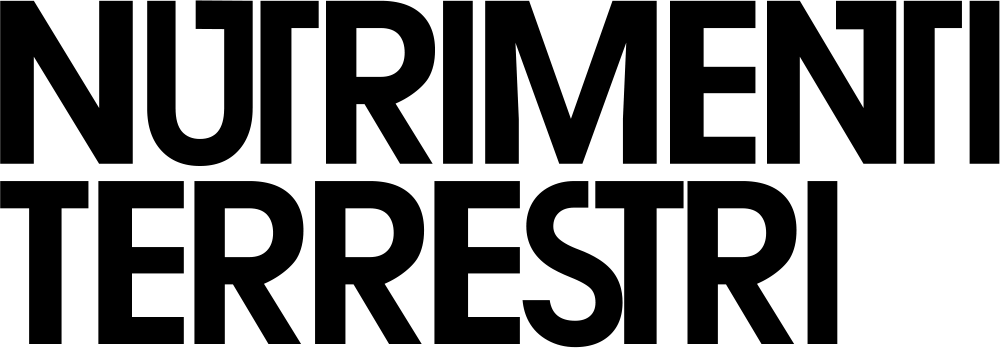di Ugo Betti
regia Ninni Bruschetta
con Antonello Cossia, Totò Onnis, Antonio Lo Presti, Giovanni Gionni Boncoddo, Giovanni Moschella, Maurizio Puglisi, Margherita Smedile
scenografia Mariella Bellantone
costumi Gabriella Eleonori
luci Renzo Di Chio
musiche Dino Scuderi
aiuto regia Roberto Zorn Bonaventura
produzione (1999)
con il Teatro Stabile delle Marche e in collaborazione con la Fondazione Ugo Betti
Nota di Pierfrancesco Giannangeli
Corruzione al palazzo di giustizia racconta una congiura, finemente elaborata, per raggiungere una posizione di potere. E lo fa con uno stile che, sorprendentemente, richiama una costruzione testuale di natura pirandelliana. Del Pirandello, per intenderci con un paio di esempi, dall’Enrico IV o di Tutto per bene, di testi cioè solidi, compiuti, con un loro percorso interno ben definito. L’inizio è problematico per chi guarda. Mezze frasi, affermazioni buttate qua e là, allusioni: la circolazione del sangue delle parole non arriva al cuore della questione. Il fatto è aggirato, agguantato per un momento e subito lasciato. Tutto è utile per far salire la tensione. Poi, nella seconda parte, dopo un avvio interlocutorio, la rilevazione. In Corruzione ne sono protagonisti Cust ed Elena (da “Sono sua figlia”) nell’Enrico IV il pazzo che non è più tale e le quattro comparse che recitano per lui (da “Buffoni! Buffoni! Buffoni!”), il duetto tra Martino Lori e Palma segna la svolta in Tutto per bene (da “Papà … figlia mia!”). Infine c’è il componimento del dramma nella terza sezione del testo: determinato, condizionato, provocato “necessariamente” da quei monologhi-dialoghi del secondo atto. In Betti l’esplosione avviene nella “partita” Cust-Croz, un duello di intelligenze profonde dove lo scintillio delle lame rischia di essere vanificato dall’amore stesso proprio alla fine, come vedremo più avanti.
Si presenta come un testo quasi perfetto nell’andamento questo di Corruzione. Un meccanismo infernale, una spirale micidiale, una morsa che si stringe intorno al collo. E, soprattutto, è un testo che finisce per vivere di vita propria, negando a Betti un ultimo, disperato tentativo di aggiustarlo, di fargli prendere una direzione che non gli appartiene più. Anzi, che non gli è mai appartenuto, fin dall’inizio. […]
La verità: uno spettro che s’aggira per le stanze, pericoloso, da evitare, da nascondere, da sopprimere con la forza. Non si sa mai, potrebbe incontrare qualche anima bella. E allora, qua, tutti sulla scena, in continuazione e per sempre.
Un concetto sottolineato da una recitazione che fa dello straniamento il suo sottofondo, per sottrarla alle tentazioni della storicizzazione.
Ancor più: uno spettacolo dove i silenzi sono fondamentali quanto le parole. Il non dire, spesso, è più insinuante del suo contrario.
Ed i contorni non definiti, le ombre, il buio (il luogo dove avvengono le confessioni) diventano essenziali per raccontare la storia.
Guai ad accendere la luce. Ci potremmo trovare di fronte ad uno specchio.